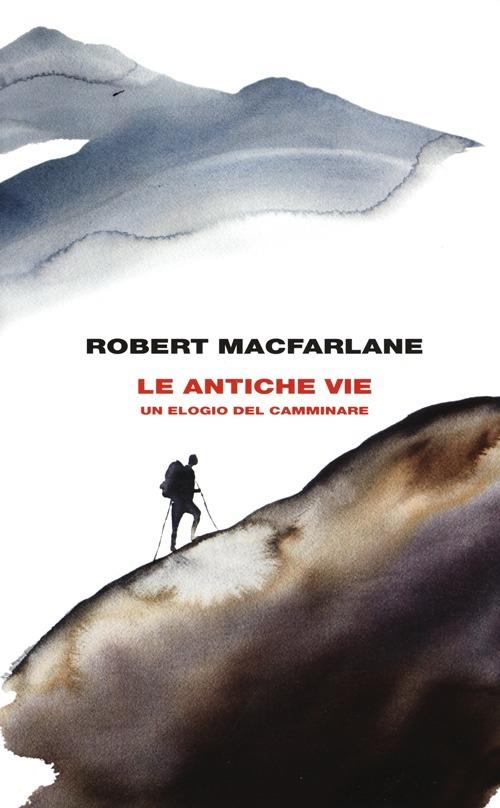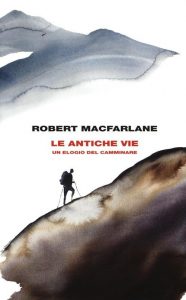 Il nome di Robert Macfarlane (1976) viene accostato a quello di autorevoli scrittori naturalisti del passato come John Muir, Richard Jefferies e Edward Thomas. Nato a Oxford nel 1976, Macfarlane completa i suoi studi nelle università di Cambridge e Oxford, per poi dedicarsi all’insegnamento: prima all’università di Beijing, successivamente, dal 2002, all’Emmanuel College della Cambridge University, dove tiene seminari di letteratura. Fra i temi che approfondisce nei suoi lavori la complementarietà fra natura e letteratura, e le modalità con cui il paesaggio permea di sé la forma romanzo, in particolare quella di epoca vittoriana. Alla pubblicazione di saggi e opere narrative affianca un prezioso contributo divulgativo collaborando con importanti testate giornalistiche, come il Guardian, il Sunday Times, l’Observer e altri ancora. Per penetrare il rapporto fra uomo contemporaneo e natura, fra nomadismo e identità territoriale, adotta un metodo di ricerca sul campo, realizzando esplorazioni e viaggi in luoghi marginali. Testimone diretto dell’antropocene, dell’alterazione degli ecosistemi per mano dell’uomo, lo scrittore inglese rinnova linguaggi e visioni, e specifica la potenza trascendente della natura incontaminata. Di Robert Macfarlane sono state pubblicate in Italia le seguenti opere: “Come le montagne conquistarono gli uomini” (vincitrice del Guardian First Book Award, del Somerset Maugham Award e del Sunday Times Young Writer of the Year Award), “Luoghi selvaggi”, “Le antiche vie”, “Montagne della mente. Storia di una passione”, “Underland” e “Un viaggio nel tempo profondo”, vincitore nel 2019 del National Outdoor Book Award per la sezione Natural History Literature.
Il nome di Robert Macfarlane (1976) viene accostato a quello di autorevoli scrittori naturalisti del passato come John Muir, Richard Jefferies e Edward Thomas. Nato a Oxford nel 1976, Macfarlane completa i suoi studi nelle università di Cambridge e Oxford, per poi dedicarsi all’insegnamento: prima all’università di Beijing, successivamente, dal 2002, all’Emmanuel College della Cambridge University, dove tiene seminari di letteratura. Fra i temi che approfondisce nei suoi lavori la complementarietà fra natura e letteratura, e le modalità con cui il paesaggio permea di sé la forma romanzo, in particolare quella di epoca vittoriana. Alla pubblicazione di saggi e opere narrative affianca un prezioso contributo divulgativo collaborando con importanti testate giornalistiche, come il Guardian, il Sunday Times, l’Observer e altri ancora. Per penetrare il rapporto fra uomo contemporaneo e natura, fra nomadismo e identità territoriale, adotta un metodo di ricerca sul campo, realizzando esplorazioni e viaggi in luoghi marginali. Testimone diretto dell’antropocene, dell’alterazione degli ecosistemi per mano dell’uomo, lo scrittore inglese rinnova linguaggi e visioni, e specifica la potenza trascendente della natura incontaminata. Di Robert Macfarlane sono state pubblicate in Italia le seguenti opere: “Come le montagne conquistarono gli uomini” (vincitrice del Guardian First Book Award, del Somerset Maugham Award e del Sunday Times Young Writer of the Year Award), “Luoghi selvaggi”, “Le antiche vie”, “Montagne della mente. Storia di una passione”, “Underland” e “Un viaggio nel tempo profondo”, vincitore nel 2019 del National Outdoor Book Award per la sezione Natural History Literature.
 Il ginevrino Nicolas Bouvier (1929-1998), dopo gli studi in storia medievale e sanscrito e un viaggio in solitaria in Norvegia, intraprende una sfolgorante carriera giornalistica: quando non ha ancora compiuto 20 anni il quotidiano La Tribune de Genève lo invia in Finlandia per effettuare un reportage, mentre due anni dopo, per conto del magazine Le Courrier, effettua un viaggio nel Sahara algerino.
Il ginevrino Nicolas Bouvier (1929-1998), dopo gli studi in storia medievale e sanscrito e un viaggio in solitaria in Norvegia, intraprende una sfolgorante carriera giornalistica: quando non ha ancora compiuto 20 anni il quotidiano La Tribune de Genève lo invia in Finlandia per effettuare un reportage, mentre due anni dopo, per conto del magazine Le Courrier, effettua un viaggio nel Sahara algerino.
La sua propensione a ricercare luoghi remoti, che mettono in discussione i propri riferimenti culturali, è proverbiale. Effettua esplorazioni estreme, che ricercano un limite rispetto al quale confrontarsi. Ed è datata 1953 l’impresa che ha contribuito a elevarlo a icona della narrativa di viaggio, itinerario che percorse a bordo di una Topolino insieme all’amico Thierry Vernet e che comprendeva Jugoslavia, Turchia, Iran, Pakistan, e in seguito, dopo la separazione da Vernet a Kabul, l’India e Ceylon (l’odierno Sri Lanka), dove Bouvier soggiornerà, in precarie condizioni di salute, per circa sette mesi.
Le corrispondenze dall’estero, negli anni a seguire, lo videro impegnato in Asia (Giappone, Corea del Sud, Cina) e in svariati paesi dell’Europa; ma resterà per sempre incisa nella memoria l’avventura di molti anni prima con l’amico Vernet, che nella sua interezza venne riportata nel libro “La polvere del mondo”, recentemente ripubblicato da Feltrinelli, ritenuto un classico del nomadismo letterario.
Altre opere per comprendere a pieno lo spirito che animava il narratore e viaggiatore svizzero (secondo Paolo Rumiz il più grande viaggiatore del secolo scorso) sono “Il pesce-scorpione” e “Diario dalle isole Aran. Carte di viaggio”.
 Ryszard Kapuściński (1932-2007), reporter, viaggiatore indefesso, cronista di eventi epocali o anche di storie minori, di donne e uomini che oggi definiremmo invisibili.
Ryszard Kapuściński (1932-2007), reporter, viaggiatore indefesso, cronista di eventi epocali o anche di storie minori, di donne e uomini che oggi definiremmo invisibili.
Nacque a Pinsk, Kapuściński, al tempo città polacca e oggi bielorussa, e i suoi primi anni di vita furono segnati dalla povertà, da condizioni di vita disagiate e dalle conseguenze prodotte dalla guerra.
Studiò a Varsavia, e in seguito si impiegò nell’agenzia di stampa Pap, per la quale lavorò fino ai primi anni ’80. Per molti un “maestro”, per alcuni un testimone inattendibile: sta in questa dicotomia l’originalità del suo percorso sui sentieri accidentati del pianeta, dimensione narrativa in cui alla puntualità dei dispacci redatti per l’agenzia di stampa si affiancava la ricerca di un punto di vista personale, fondato sulla competenza e sulla revisione critica.
Idealizzando un faro puntato sulla storia del 900, risulta inappropriato non collocare Ryszard Kapuściński, insieme a pochi altri, alle spalle di questa fonte di luce in qualità di osservatore, esegeta dell’umanità e delle spinte – benevole o distruttive – che ne hanno contraddistinto il cammino.
Riferì nei suoi articoli di colpi di stato, rivoluzioni, guerre civili, rischiando più volte la vita e viaggiando senza sosta dentro una sorta di esplorazione capillare, dalle società complesse – meccanismi attigui all’insondabilità – ai singoli individui. Fra le sue mete abituali l’Africa, pressoché nella sua interezza, il Medio Oriente, l’URSS, sempre con l’obiettivo di scrivere non soltanto per uno specifico committente ma per tutti coloro che – riferì in un intervista all’agenzia Reuters – “si sentono abbastanza giovani per rimanere curiosi del mondo”. La sua produzione letteraria e saggistica è assai cospicua: fra i suoi libri più conosciuti “Se tutta l’Africa”, “Il Negus: splendori e miserie di un autocrate, “Shah-in-Shah”, dedicato all’Iran, “Imperium”, resoconto di un viaggio nelle quindici repubbliche sovietiche, effettuato tra il 1989 e il 1992, “Ebano” e “In viaggio con Erodoto”.
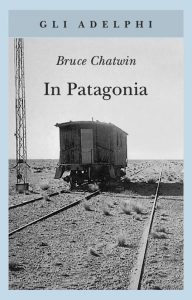 Recettori sensoriali tarati sulla bellezza, Charles Bruce Chatwin (1940-1989) nel 1958, a 18 anni, inizia a lavorare per la casa d’aste londinese Sotheby’s. Dapprima svolge le mansioni “da matricola”, ed è appunto il suo talento visivo a permettergli, in breve tempo, di scalare le gerarchie della prestigiosa istituzione britannica. Ma l’irrequietezza è un altro aspetto caratteriale che lo contraddistingue: infatti a 26 anni abbandona il lavoro di esperto d’arte per tuffarsi nello studio dell’archeologia, iscrivendosi all’Università di Edimburgo e mantenendosi agli studi comprando e vendendo quadri. Il suo primo viaggio importante lo compie in Afghanistan, nel 1969, e grazie ai suoi primi articoli viene notato dal Sunday Times Magazine, che lo assume come consulente d’arte e architettura. Il mestiere di giornalista gli permette di affinare la sua tecnica di scrittura, e soprattutto di viaggiare in lungo e in largo nei cinque continenti incontrando personaggi di grande spessore (fra gli altri André Malraux, Nadežda Mandel’štam, Indira Gandhi) e avvicinando popolazioni e culture fino ad allora poco conosciute.
Recettori sensoriali tarati sulla bellezza, Charles Bruce Chatwin (1940-1989) nel 1958, a 18 anni, inizia a lavorare per la casa d’aste londinese Sotheby’s. Dapprima svolge le mansioni “da matricola”, ed è appunto il suo talento visivo a permettergli, in breve tempo, di scalare le gerarchie della prestigiosa istituzione britannica. Ma l’irrequietezza è un altro aspetto caratteriale che lo contraddistingue: infatti a 26 anni abbandona il lavoro di esperto d’arte per tuffarsi nello studio dell’archeologia, iscrivendosi all’Università di Edimburgo e mantenendosi agli studi comprando e vendendo quadri. Il suo primo viaggio importante lo compie in Afghanistan, nel 1969, e grazie ai suoi primi articoli viene notato dal Sunday Times Magazine, che lo assume come consulente d’arte e architettura. Il mestiere di giornalista gli permette di affinare la sua tecnica di scrittura, e soprattutto di viaggiare in lungo e in largo nei cinque continenti incontrando personaggi di grande spessore (fra gli altri André Malraux, Nadežda Mandel’štam, Indira Gandhi) e avvicinando popolazioni e culture fino ad allora poco conosciute.
Il nome di Chatwin resta indissolubilmente legato al capolavoro della narrativa di viaggio “In Patagonia”, pubblicato nel 1977. L’origine del libro, le motivazioni che ne hanno determinato la stesura, risalgono all’incontro che Chatwin ebbe a Parigi con l’architetto – allora novantatreenne – Eileen Gray. Su una parete dello studio della pioniera dell’estetica International Style campeggiava una mappa della Patagonia, regione geografica nell’estremo sud dell’America Latina che aveva sempre attratto il giornalista e scrittore. “Non ci sono mai stata” confessò Eileen Gray, notando l’interesse del suo ospite per quella suggestiva terra ai confini del mondo, “perché non ci va lei al mio posto?” lo sollecitò d’appresso con una nota malinconica nella voce e Chatwin non se lo fece ripetere due volte: partì quasi immediatamente e una volta giunto a destinazione inviò un telegramma al giornale annunciando le sue dimissioni. Restò circa sei mesi in Patagonia, assommando esperienze e riflessioni che poi ricapitolò nel suo libro più celebre. Completano il percorso letterario di Bruce Chatwin i volumi “Il viceré di Ouidah”, “Sulla collina nera”, “Ritorno in Patagonia”, “Le vie dei canti”, “Utz”, “Che ci faccio qui?”.
 Disamina o coinvolgimento, slancio professionale o attenzione verso i temi sociali: ostico inquadrare l’opera del triestino Paolo Rumiz (1947), identificarne un nucleo espansivo, una ragione profonda. Per semplicità possiamo inquadrarlo in un ruolo, quello del giornalista (straordinari i suoi reportage per La Repubblica), ma anche rispetto alla mansione del “riferire i fatti” permane un’impressione di imprevedibilità, di scarto programmatico. Di certo sul campo – biro e taccuini pronti all’uso -, Paolo Rumiz ha testimoniato eventi che hanno contraddistinto gli anni a cavallo fra XX e XXI secolo, come la guerra civile in Croazia e Bosnia-Erzegovina, o l’attacco degli Stati Uniti d’America all’Afghanistan talebano nel 2001; in ogni caso la sua sensibilità, l’intuito che gli permette di dissodare le zone nevralgiche della Storia, gli hanno consentito di comporre un’opera a più chiavi di lettura, in cui pubblico e privato si amalgamano e il passato viene traslato in un presente in continua trasformazione.
Disamina o coinvolgimento, slancio professionale o attenzione verso i temi sociali: ostico inquadrare l’opera del triestino Paolo Rumiz (1947), identificarne un nucleo espansivo, una ragione profonda. Per semplicità possiamo inquadrarlo in un ruolo, quello del giornalista (straordinari i suoi reportage per La Repubblica), ma anche rispetto alla mansione del “riferire i fatti” permane un’impressione di imprevedibilità, di scarto programmatico. Di certo sul campo – biro e taccuini pronti all’uso -, Paolo Rumiz ha testimoniato eventi che hanno contraddistinto gli anni a cavallo fra XX e XXI secolo, come la guerra civile in Croazia e Bosnia-Erzegovina, o l’attacco degli Stati Uniti d’America all’Afghanistan talebano nel 2001; in ogni caso la sua sensibilità, l’intuito che gli permette di dissodare le zone nevralgiche della Storia, gli hanno consentito di comporre un’opera a più chiavi di lettura, in cui pubblico e privato si amalgamano e il passato viene traslato in un presente in continua trasformazione.
Racconti, o meglio diari di viaggio, resoconti puntuali e amorevoli nel medesimo tempo, con amici o immerso in una solitudine avvertita come inevitabile (ne “Il Ciclope” del 2014 mette nero su bianco le esperienze di vita su un’isola deserta dominata da un faro); le mete predilette, o almeno più usuali, richiedono uno spostamento verso est, o da est a un’identità territoriale adriatica, in un fluire che evoca conflitti, scismi, interlocuzioni e contrapposizioni religiose. Navigazioni marittime e fluviali, le rotte della Serenissima e il Danubio; il tempo sospeso delle tratte ferroviarie, per raccontare le contraddizioni dell’Europa da Trieste a Istanbul; gli spostamenti aleatori e a singhiozzo (bus, autostop, traghetti, bicicletta) avendo in dotazione il consueto passepartout culturale, che discerne e sfronda le rappresentazioni di comodo. Problematico cogliere dal mazzo i libri più rappresentativi di Paolo Rumiz; utilizzando una sorta di criterio geografico e centripeto ricordiamo “È Oriente”, “La cotogna di Istanbul”, “Trans Europa Express”, “Il filo infinito. Viaggio alle radici d’Europa”, “Morimondo”, “Il veliero sul tetto. Appunti per una clausura”, nel quale racconta l’esperienza del lockdown nei primi mesi del 2020.